 In un libro, la storia e le immagini di mezzo secolo di carriera del baritono Renato Bruson, impareggiabile mattatore sui palcoscenici dei teatri lirici del mondo
In un libro, la storia e le immagini di mezzo secolo di carriera del baritono Renato Bruson, impareggiabile mattatore sui palcoscenici dei teatri lirici del mondo
di Renzo Allegri
Al Ridotto dei Palchi “Arturo Toscanini” del Teatro alla Scala a Milano, è stato presentato il libro “Renato Bruson. Il volto, il gesto, il passo”. Un volume, edito da Grafiche Step di Parma, dedicato ai cinquant’anni di carriera del grande baritono italiano.
L’aggettivo “grande”, pur suggerendo significati certamente straordinari, non “rispecchia” appieno l’uomo e l’artista Renato Bruson. Uomo e artista che sono un tutt’uno, indivisibili, con una personalità scolpita, inconfondibile, che lo ha già inserito di diritto nella leggenda.
Il libro, prevalentemente fotografico, delinea soprattutto l’itinerario della carriera di Bruson. E’ stato curato con grande amore da Tita Tegano, moglie dell’artista, che, con la competenza che viene dalla sua professione di pittrice e scenografa, ha dato al tutto eleganza e raffinatezza. Il libro offre agli appassionati e agli ammiratori un quadro ampio delle immagini di questo artista nelle varie “incarnazioni” dei personaggi lirici da lui interpretati. Manca, in un certo senso, ( ma questo non era nel progetto del libro), un approccio “live” con l’”uomo” Bruson, con la sua “quotidianità”, con i “passi” compiuti nei sentieri difficili della vita reale, soprattutto quelli degli inizi di carriera, che stanno a fondamento delle vette artistiche poi raggiunte. Mancanza che, nel caso di Bruson, potrebbe essere dipesa da una precisa decisione dell’artista che rifugge dal parlare di se.
Questo sua riluttanza mi è ben nota. Conosco Bruson da molti anni. L’ho intervistato diverse volte, e sempre con fatica. Le sue erano risposte brevi, asciutte e, quando si trattava di raccontare di sé, diventava telegrafico.
E’ un personaggio ostico. <<Non sono in pace con me stesso>>, si giustificava. <<E non riesco a nasconderlo. Per questo non sono una persona amabile>>.
E’ stato spesso definito “burbero”, “taciturno”, “introverso”, “dal carattere collerico”. Ma sono definizioni superficiali che non corrispondono al vero. E’ piuttosto un inquieto perfezionista, nell’arte come nella vita, mai contento di se stesso e cocciuto nel voler raggiungere le mete che si prefigge. Questo stato d’animo, permanente in lui, quasi congenito, lo tiene in una continua tensione interiore e lo mette in conflitto con l’andazzo remissivo del vivere e del fare, tipico della nostra società. Bruson non accetta questo andazzo. Non lo sopporta negli altri. Lo odia e lo detesta nel mondo dell’arte.
 <<Che cosa pensi di fare quando non canterai più?>>, gli ho chiesto un giorno intendendo sapere se avrebbe scelto l’insegnamento o se pensava invece di ritirarsi definitivamente dalla vita artistica.
<<Che cosa pensi di fare quando non canterai più?>>, gli ho chiesto un giorno intendendo sapere se avrebbe scelto l’insegnamento o se pensava invece di ritirarsi definitivamente dalla vita artistica.
Mi ha guardato con occhi corrucciati ed ha risposto: <<Penso che farò probabilmente il guerrigliero. Imbraccerò un mitra e andrò a fare piazza pulita di tante schifezze, ingiustizie e sopraffazioni>>. Ha poi sorriso, trasformando il ghigno indignato del viso in un’espressione dolce e remissiva. Quella che viene dal profondo del suo animo e che rivela il vero Renato Bruson, ma che egli tiene da sempre gelosamente nascosta.
<<Nessuno lo conosce a fondo>>, mi disse sua moglie, Tita Tegano. <<Neppure io lo conosco bene anche se gli sto accanto da una vita. E’ uno che non si rivela mai completamente. Credo non voglia farlo, o forse non ci riesce>>.
Uomo di complessa interpretazione quindi, mentre, come artista, è assolutamente solare. Tutti i critici, anche i suoi nemici, sono concordi nel ritenere che sia un grandissimo cantante lirico. Paragonabile solo agli interpreti leggendari del passato, quelli che hanno fatto la storia del melodramma.
Emerge per la qualità della voce: pastosa, morbida, di colore e compattezza perfettamente omogenei per tutta l’intera gamma; per il carattere dell’emissione: controllata, dosata, con scelte espressive mai banali; per la chiarezza e nobiltà del fraseggio, che raggiunge i livelli massimi della parola cantata; e infine per la raffinatezza, l’eleganza, la fierezza dell’interpretazione, che pone Bruson nella ristretta rosa dei grandi cantanti-attori. E tutto questo non per frutto del caso, ma ottenuto con studio approfondito, con l’utilizzo intelligente dei suoi eccezionali doni naturali, potenziati da una tecnica esemplare tenacemente affinata e consolidata nel corso degli anni.
 Nato a Granzè, in provincia di Padova, nel 1934, Renato Bruson è figlio di povera gente. Perse la madre ancora bambino e ne soffrì molto. Si è costruito un avvenire da solo. Ma non spinto dalla smania di emergere, di affermarsi di fronte agli altri, come succede quasi sempre. Ma, caso quasi unico, per arricchire se stesso, per placare quell’irrefrenabile desiderio interiore di perfezione, di bellezza, di arte, che lo tormenta.
Nato a Granzè, in provincia di Padova, nel 1934, Renato Bruson è figlio di povera gente. Perse la madre ancora bambino e ne soffrì molto. Si è costruito un avvenire da solo. Ma non spinto dalla smania di emergere, di affermarsi di fronte agli altri, come succede quasi sempre. Ma, caso quasi unico, per arricchire se stesso, per placare quell’irrefrenabile desiderio interiore di perfezione, di bellezza, di arte, che lo tormenta.
Non ha mai perseguito il successo ad ogni costo: per questo la sua carriera è stata lenta e faticosa. Non si è mai ritenuto un “arrivato”: per questo la sua arte non palesa stanchezze. Non ha mai tradito la musica: per questo ha litigato molto e si è fatto la fama di uomo difficile. Ma ha servito il Teatro lirico come pochi.
Bruson non ama le interviste. Ma se è in vena di conversare e sente intorno a sé una atmosfera di amicizia e di fiducia, si abbandona a confidenze preziose. La sue risposte non sono mai ovvie. O tace o dice cose che vengono dal di dentro, dal suo riflettere e pensare, risposte quindi importanti.
Un giorno sono andato a trovarlo a Salsomaggiore, dove stava facendo delle cure termali. Il mensile giapponese “Ongaku No Tomo”, prestigiosa rivista che si interessa solamente di musica sinfonica e lirica, con la quale ho collaborato per dieci anni, mi aveva chiesto di intervistarlo. Il sapere, forse, che l’intervista sarebbe uscita su una rivista straniera, in un Paese tanto lontano, o forse anche per il calore dell’amicizia che mi ha sempre dimostrato, in quell’occasione Renato Bruson è stato loquace. Seduti all’ombra dei grandi alberi del giardino dell’Hotel Milano, Renato, si è lasciato andare ai ricordi, regalandomi una intervista ricca di fatti, dettagli, impressioni, giudizi. Intervista che è un vero documento storico per quanto riguarda questo artista, e che in Giappone, Paese dove Bruson gode di una ammirazione sconfinata, è stata pubblicata su otto pagine. Mi fa perciò piacere riproporla, almeno in parte, in questa pagine che so essere lette da molti appassionati di lirica e ammiratori di Bruson.
Ca ro Renato, se dovessi ricominciare la tua vita da capo, rifaresti questa professione?
ro Renato, se dovessi ricominciare la tua vita da capo, rifaresti questa professione?
<<E come potrei non farla? E’ una professione che mi ha dato grandissime soddisfazioni. Chiaramente ho dovuto lottare, soffrire, e continuo a farlo tuttora. Ma d’altra parte, chi è che non lotta nella vita per ottenere quello che vuole? E poi devo dire che mi piace lottare>>.
Quando hai cominciato a sognare di diventare un famoso cantante lirico?
<<Per la verità io non ho mai sognato di fare il cantante lirico. E’ stato per caso che ho iniziato a studiare canto. Ero disoccupato e ogni tanto mi assumevano nei cantieri come manovale. Eravamo negli anni dell’immediato dopoguerra. A quel tempo c’erano poche strade asfaltate, erano quasi tutte sterrate. E il mio compito era proprio quello di riempire di sabbia le buche che si creavano sulle strade. Ricordo che la paga era di cinquecento lire al giorno. Quindi, a tutto potevo pensare tranne che a diventare un cantante>>.
 Quando hai scoperto di amare la lirica?
Quando hai scoperto di amare la lirica?
<<Tardi. Fino verso a 15 anni non sapevo neppure che cosa fosse, quindi non mi piaceva affatto. In casa non avevamo la radio e io, appassionato di sport e soprattutto di ciclismo, andavo dagli amici che l’avevano solo per ascoltare gli arrivi delle tappe del Giro ciclistico d’Italia” e per sentire le canzonette del Festival di San Remo. Le conoscevo tutte. Ma non sapevo riconoscere nessuna aria di Verdi. Era un genere che non mi piaceva.
<<Nel 1950 arrivò nel mio paese un parroco nuovo, don Sergio, ed era appassionato di lirica. Fu lui a farmi scoprire l’opera. Aveva una grande collezione di spartiti e un giorno mi disse di andare da lui per ascoltare la lirica alla radio. Era il 1951, l’anno del Cinquantesimo anniversario della morte di Verdi. Quella sera trasmettevano il Nabucco. Ascoltai l’opera, seguendola sullo spartito e mi appassionai. Continuai ad ascoltare le opere alla radio. L’anno dopo, quel prete mi portò per la prima volta all’Arena di Verona. Ricordo che viaggiammo sulla sua moto, percorrendo tutte stradine sterrate secondarie da Granzè a Verona, un centinaio di chilometri circa. Quando arrivammo, la sua tonaca non era più nera ma quasi bianca dalla polvere. Vedemmo la Gioconda, diretta dal maestro Votto, con Maria Callas. Da quel momento la lirica mi entrò nel cuore>>.
E hai cominciato a sognare la grande carriera.
<<Non diciamo fesserie. Il canto mi è sempre piaciuto. Da bambino cantavo in chiesa, e qualche volta, da voce bianca, avevo fatto anche il solista. Poi, con l’età, la voce era cambiata. Avevo continuato a far parte del coro in chiesa. Ero diventato tenore, poi basso. I miei amici mi dicevano che avevo una bella voce e che dovevo farla sentire a qualcuno che se ne intendeva. Dopo quella “Gioconda” in Arena ho cominciato a prendere in considerazione la possibilità. A Padova c’erano delle audizioni per il teatro e gli amici mi convinsero a partecipare. Mio cugino mi prestò la giacca, un paio di pantaloni e anche le duecento lire necessarie per l’iscrizione.
<<L’audizione la tenne il maestro Pedrollo, e devo dire che andò bene. Mi fecero chiamare e mi chiesero che intenzioni avevo, se volevo cioè studiare canto. Dissi con franchezza che avevo partecipato a quella audizione solo per curiosità e che non avevo i mezzi economici per studiare.
<<Tutto sembrò finire lì. Passarono tre mesi e, poco prima di Natale, la commissione del teatro mi fece chiamare. Avevano deciso di assegnarmi una specie di borsa di studio perché potessi studiare al Conservatorio di Padova. . Mi avrebbero pagato il viaggio da Granzè a Padova, le tasse e anche il vitto per quei giorni in cui dovevo restare tutto il giorno in Conservatorio. Mi lasciai convincere e cominciai. Ma fin dall’inizio non miravo a nulla. Per natura io sono un pessimista e a quel tempo lo ero molto di più. La vita non mi aveva dato altro che difficoltà e avevo sempre dovuto lottare coi denti per qualsiasi cosa. Era ovvio quindi che il mio atteggiamento fosse guardingo e sospettoso.
<<Gli insegnanti parevano davvero convinti che io potessi fare qualcosa di buono nel mondo della lirica ma io non ci credevo. Mi mettevo a litigare spesso con loro perché ero convinto che, lodandomi, mi prendessero in giro. Non avevo la minima fiducia nelle mie possibilità. A casa poi, non avevo alcun appoggio. Anzi, mi erano tutti contro. Il periodo era quello del dopoguerra, la mentalità del paese era ristretta, la mia famiglia era povera. Io, con il mio studio del canto, passavo per quello che non ha voglia di fare nulla. I miei parenti dicevano che non avevo voglia di lavorare e di farmi una posizione ed erano scandalizzati che mio padre continuasse a lasciarmi andare a Padova a studiare. Ad un certo momento anche mio padre mi si mise contro e per poter continuare gli studi, dovetti lasciare il paese, andare in esilio. In pratica fino a quando non arrivò il primo grande successo, nel 1967 a Parma, non pensai mai di poter mantenermi facendo il cantante>>.
 Però già nel 1961 avevi vinto un importante concorso, quello di Spoleto.
Però già nel 1961 avevi vinto un importante concorso, quello di Spoleto.
<<Sì. E avevo debuttato con successo in teatro. Ma poi seguirono altri anni di tremende difficoltà che non facevano sperare niente di buono>>.
Quando ti sei diplomato al Conservatorio di Padova?
Non mi sono mai diplomato. All’ultimo anno me ne sono andato. Ero stato rimandato in letteratura poetica e drammatica e così quell’anno dovetti ripetere il corso. L’insegnate era la stessa dell’anno prima. Lei non usava il libro di testo ma dettava quello che avremmo dovuto studiare. Mi accorsi che dettava le stesse, precise cose dell’anno precedente. Così io non scrivevo. “Bruson!”, mi disse “Perché lei non scrive?”. “Perché sono le stesse cose che mi ha fatto scrivere l’anno scorso”, risposi. “Ma come si permette?”, disse lei infuriata. “Se vuole possiamo confrontarle”, aggiunsi. E allora lei mi sospese. E io me andai del tutto. Avevo vinto il Festival di Spoleto, e lo avevo vinto alla grande, pensavo di poter cominciare a guadagnare qualche cosa. Ma era un’illusione>>
Come mai?
<<Non lo so. In quel periodo ero bersagliato dalla sfortuna. Nel 1962 mi stabilii a Roma, perché nella capitale potevano nascere le occasioni di lavoro. Potei studiare con vari maestri del Teatro dell’Opera e sostenere delle piccole parti in teatro, ma niente di più.
<<L’attesa, durissima, continuò per cinque anni. Finalmente nel 1967 fui chiamato dal Regio di Parma. L’opera era la Forza del destino, con Franco Corelli. C’era moltissima attesa e fu per me un battesimo straordinario, che segnò il vero inizio della mia carriera. In sala c’era Roberto Bauer, incaricato dal Metropolitan di cercare voci nuove. Venne a congratularsi e mi fissò un appuntamento con il sovrintendente del Metropolitan, Rudolf Bing. L’anno successivo andai a New York e debuttai al Met. Bing voleva che restassi la, pagato mensilmente. Io rifiutai perché non mi piaceva l’America. Lui si risentì e finchè rimase direttore io non ho più messo piede al Met>>.
 Quali le altre tappe importanti dell’inizio della tua carriera?
Quali le altre tappe importanti dell’inizio della tua carriera?
<< Dopo il debutto al Metropolitan di New York nel 1968, considero una tappa importante il debutto al San Carlo di Napoli con il Lohengrin, in italiano, nel 1969. Opera difficile, ma grande esperienza per me. Poi il debutto alla Scala di Milano nel 1972, con Linda di Chamounix e il debutto all’Arena di Verona nel 1975. Fu il commendator Cappelli, sovrintendente ad insistere perché andassi a cantare in Arena. Erano tre anni che mi faceva proposte ma io avevo sempre detto di no perché le opere che mi voleva far cantare non erano del mio repertorio. Alla fine, il quarto anno, mi offrì Forza del Destino, l’opera con la quale avevo debuttato a Parma e che mi aveva sempre portato fortuna. Solo allora accettai e fu un successo. Da allora la mia carriera non ebbe tregua>>.
Nella carriera di ogni artista ci sono serate magiche che, per successo o per emozioni, non si possono dimenticare mai. Ne puoi citare qualcuna?
<<Parma, sicuramente, con il mio vero debutto nel 1967. Il debutto non si può dimenticare. Parma era allora considerata una piazza davvero molto difficile. A renderla tale era il pubblico, esigente e competente. In quella città o si ottenevano grandi successi o fischi. Se andava bene, voleva dire che si aveva proprio cantato come si deve. Ricordo che tra i cantanti la tensioni si respirava addirittura settimane prima. Parma metteva davvero paura. Corelli era pallido come un cadavere. Immagina come mi sentivo io. Ma andò benissimo e il ricordo di quel successo è inciso a fuoco nel mio animo.
<<Fra le tante altre serate rimaste indelebili nei miei pensieri, .quella che forse mi ha dato la più viva emozione artistica la vissi a Vienna nel 1984. L’opera era il Simon Boccanegra, una produzione della Scala con la regia di Giorgio Strehler. Come ho già detto, il Simon Boccanegra è un’opera che io adoro. Il finale mi ha sempre commosso, al punto che fin dalle prime volte in cui ho interpretato quest’opera, ho dovuto imparare a controllarmi, per non incrinare la voce a causa della commozione. A Vienna, quella sera, fu un’apoteosi. Nel 1984 avevo già fatto circa cento recite del Simon Boccanegra. Lo avevo assimilato bene. Era entrato dentro di me al punto che quando lo interpretavo riuscivo veramente a immedesimarmi. Per cui, in quel teatro, a Vienna, con Claudio Abbado sul podio, ho dato veramente il meglio di me stesso. Alla fine dell’opera, si chiuse il sipario e fu silenzio. Il pubblico era così preso, così coinvolto, che non applaudì. Niente. Silenzio assoluto. Furono attimi da infarto, non per la paura che l’opera non fosse piaciuta, ma perché sentivi che perfino l’aria era elettrizzata dall’emozione che coinvolgeva tutti. Naturalmente dopo alcuni attimi si è scatenato il finimondo di entusiasmo con battimano interminabili. Ma furono proprio quegli attimi di silenzio a decretare il successo della recita. In seguito ho ricevuto anche delle lettere. Persone, presenti a Vienna quella sera, mi scrivevano dicendo che, dopo aver assistito a quella recita, la loro vita era cambiata. Questo per me è stato il massimo di soddisfazione che un artista possa avere dal suo lavoro>>.
<<Non mancano mai nel corso della carriera e per le ragioni più disparate. Però devo dire che sono stato fortunato perché non ho ricordi di recite andate davvero storte, in modo disastroso. Qualcuna burrascosa l’ho avuta. Ricordo un Trovatore a Parma. Era il 1969, e cantavo con Richard Tucker e Katia Ricciarelli. Fin dalle prime note si capiva che tra il pubblico c’era aria di contestazione. Si voleva a tutti i coste, forse per ragioni politiche, rovinare la serata. L’opera di per sé andava avanti abbastanza bene. Ma al termine di ogni aria oltre agli applausi si sentivano zitti e qualche fischio. Ingiustificati, nel modo più assoluto. E ad un certo momento mi arrabbiai. Non potevo accettare quelle critiche stupide e uscii di scena. Tutti si misero a cercarmi per convincermi a tornare sul palco, ma io non demordevo. Furono costretti a spingermi. E mentre mi spingevano e io mi ritraevo deciso a non salire sul palco, scattò il flash di un fotografo. “Chi è stato? Chi ha fatto la foto?” urlai furioso. E vidi un fotografo che scappava. Io ero vestito con il costume e portavo la spada. Brandii l’arma e lanciando fendenti in aria cominciai a rincorrere il fotografo urlando come un forsennato. I colleghi, il personale mi rincorreva temendo che facessi un macello. Una scena veramente comica. Ma ero così infuriato che se fossi riuscito a prendere quel fotografo gli avrei veramente fatto del male. Penso che quella sia stata l’unica serata in cui le cose non sono andate come dovevano. E la colpa fu mia. Se io avessi gestito meglio la vicenda, tenendo i nervi a posto, non sarebbe successo niente. Non avrei dovuto reagire. Ma ero giovane e avevo forse un po’ la testa calda anch’io>>.
 Canti da quasi mezzo secolo: è un mestiere duro?
Canti da quasi mezzo secolo: è un mestiere duro?
<<Lo è. E richiede molti sacrifici. Soprattutto molto studio. Bisogna studiare continuamente e seriamente. Stare attenti alle opere che si sentono, e studiare. Con il termine sacrifici intendo anche quello di saper rinunciare ai facili guadagni. Si deve sempre stare attenti a non accettare proposte allettanti perchè possono fare più male che bene. La carriera si fa con i no! Io ricordo quando Muti mi chiamò a Firenze, per fare “Guglielmo Tell”. Gli dissi: “Maestro, io la ringrazio ma non me la sento ancora di fare questa opera.” E lui se la legò al dito e quando rifece quell’opera alla Scala, non mi chiamò. Ma non ha importanza. Dopo una lunga carriera, canto ancora regolarmente. Questo è ciò che conta. Ho conosciuto giovani con belle voci, grandi speranze, ma che poi si sono bruciati perché non hanno saputo amministrarsi con prudenza>>.
Tutti i critici hanno sempre messo in evidenza, nella loro recensioni, che tu sei un cantante-attore. Che i tuoi successi non sono solo legati alla tua voce, ma anche al tuo modo di recitare. Massimo Mila, dopo il tuo “Otello” del 1987 alla Scala, scrisse: “Bruson ha dominato dentro la regola aurea dello stile, sentito dall’artista come una seconda natura”. Giudizio strepitoso, tenendo conto che viene dal “principe” dei critici di musica italiani. A proposito, come sono stati i tuoi rapporti con la critica?
<<Devo dire che sono sempre stati abbastanza buoni. Ho sempre accettato le critiche costruttive ma mi sono sempre scontrato con la critica distruttiva, fatta solo per offendere e denigrare. E poi non ho mai sopportato i critici che parlano bene di te e poi si aspettano dei ringraziamenti. Io non ho mai detto grazie a nessun critico. Ma come? Grazie per che cosa? Io sul palcoscenico ho fatto il mio dovere, il mio lavoro. E il critico deve fare il suo, di lavoro, scrivendo bene o male.
<<Riguardo al giudizio di Mila che hai citato, mi ha fatto molto felice. Soprattutto perché fa riferimento all’Otello. Il personaggio di Iago è per me come una seconda pelle e sulle scena lo vivo come se fossi io personalmente. Amo molto quel ruolo e se ne parlano bene mi fa piacere perché significa che hanno capito la dedizione con cui lo interpreto>>.
 I critici hanno anche sempre esaltato la tua regalità, la tua signorilità, la nobiltà e l’eleganza del gesto, degli atteggiamenti, da autentico attore.
I critici hanno anche sempre esaltato la tua regalità, la tua signorilità, la nobiltà e l’eleganza del gesto, degli atteggiamenti, da autentico attore.
<<Devo ringraziare per questo i miei maestri. Loro mi hanno insegnato come cantare ma anche come muovermi, come atteggiarsi. Erano maestri che amavano il teatro e soprattutto amavano i giovani. Persone straordinarie che ora non ci sono più. E questo è un grandissimo peccato, perché i giovani cantanti di oggi non possono più godere dei loro consigli. Quelle persone mi spiegavano non solo come si doveva cantare ma anche come dovevo muovermi, parlare, gesticolare. Io ero giovane e assimilavo molto.
<<Durante la mia carriera poi, ho sempre avuto l’umiltà di andare da quelli che erano già arrivati in cima a chiedere consigli. E da loro ho sempre imparato moltissimo. Per esempio, ho ricevuto bellissime lezioni da Tito Gobbi e da Boris Christoff. Con l’aiuto dei miei maestri e dei grandi interpreti più anziani di me ho sempre cercato di approfondire i miei personaggi. Quando si trattava di personaggi storici, ricorrevo anche all’aiuto di libri per conoscere tutto della loro vita reale, della loro attività, delle loro imprese. I ruoli di personaggi storici sono quelli che ho preferito in assoluto e infatti, parti un po’ banali, come quelle del “Ballo in maschera” o del “Trovatore” con il tempo non le ho più volute fare. Non mi davano la possibilità di leggere dentro i personaggi>>.
 Quando affronti un personaggio nuovo, come procedi nella preparazione?
Quando affronti un personaggio nuovo, come procedi nella preparazione?
<<Prima di tutto leggo bene il testo dell’opera. Quindi, cerco di documentarmi il più possibile su quel personaggio. Se è realmente esistito non è difficile, si cerca nei libri di storia. Se invece è un personaggio di fantasia, allora mi informo sul suo autore, su quello che ha voluto dire, sul tempo storico in cui lo ha ambientato eccetera. Solo dopo questa preparazione, comincio a prendere in considerazione la musica.
<<Io non ho mai studiato le opere nuove a corpo morto, gettandomi sullo spartito per settimane di fila. Ho sempre usato una mia tecnica graduale e per nulla stressante. Studio l’opera per una settimana e poi la metto da parte. La riprendo dopo dieci giorni e la studio per un’altra settimana e la rimetto ancora da parte. Quando la riprendo dopo un’altra lunga pausa, la so a memoria. Nei periodi di riposo, il cervello continua a lavorare, a vagliare, a soppesare. Ciò che ho studiato sedimenta, matura, si assesta, prende forma, evidenzia lacune e difetti. Imparando la parte in questo modo non solo non la si dimentica mai più, ma prende forma dentro di te, diventando parte della tua personalità, quasi del tuo sangue. E quando sali sul palcoscenico ti senti immedesimato in essa.
<<Purtroppo, oggi i giovani non hanno una tecnica di studio. Non ci sono insegnanti che gliela suggeriscano. Sai cosa fanno? Studiano le opere sui dischi. E’ la cosa più sbagliata del mondo. Anche se non vuoi, in questo modo tendi per forza ad imitare e rovini te stesso>>.
 Cosa pensi di certi registi moderni che vogliono stravolgere le indicazioni dei compositori?
Cosa pensi di certi registi moderni che vogliono stravolgere le indicazioni dei compositori?
<<La maggior parte di essi, per non dire quasi tutti, si preoccupano solo del quadretto che stanno allestendo. Il resto, per loro, non conta. Peccato che il resto sia l’opera lirica stessa.
<<Penso che, oggi, molti registi cerchino solo di sfogare nelle scenografie i loro istinti repressi. Cambiano tutto, anche lo stile stesso dell’opera. Non si interessano all’interpretazione dei personaggi. Così manipolano i giovani cantanti, i quali si trovano sul palco, in un contesto moderno, quindi strano, sentendosi a disagio e non sapendo per niente cosa devono fare. Questo perché il regista non dice loro nulla. E’ chiaro che poi l’opera va male. Ma questo non è un guaio per loro. Oggi l’importante è far parlare, e i registi allora cercano di fare cose sempre più strane. Proprio per far parlare. L’assurdo è che poi pretendono anche di spiegarti l’iter psicologico che li ha portati a quella scelta. Per esempio, al Teatro Sperimentale di Spoleto hanno allestito, anni fa, una Tosca dove, nella scena del “Te Deum”, al posto dei chierichetti c’erano delle ragazze a seno nudo. Ma ti pare possibile?
<<Io più di una volta ho litigato con registi di questo tipo e sono stato costretto ad andarmene. Mi ricordo di una recita di Otello a Macerata. Invece del costume di Iago, il regista voleva che indossassi un vestito bianco, tenessi un gatto in mano e portassi il monocolo. Siccome Iago è un cattivo, il regista voleva che fossi vestito come il cattivo dei film di 007. “Io voglio fare Iago come lo avevano in mente Verdi e Boito”, ho protestato. “O il costume è come dico io o vi trovate un altro interprete”. Alla fine io ho indossato il costume classico. Ma ero l’unico in quell’allestimento>>.
Quante opere hai in repertorio?
<<Una settantina. Ma mi riferisco alle opere interpretate in teatro, sulla scena, con i costumi. Perché poi ce ne sono tante altre che ho fatto solo in forma di concerto oppure che ho cantato per un’incisione discografica. Se teniamo conto anche di queste, il repertorio sale a circa 110 opere>>
I tuoi cavalli di battaglia?
<<In testa c’è Il Macbeth di Verdi. Poi il Simon Boccanegra, Rigoletto, Traviata. Ho fatto tante recite anche di Don Carlos. Insomma, come vedi, opere di Verdi>>.
Quali i personaggi che più ti piacciono?
<<Falstaff , Iago e Simon Boccanegra. Quando stavo per debuttare in questo ruolo, nel 1976, ebbi la fortuna di stare una ventina di giorni con Tito Gobbi, che fu un mitico Simone. Ogni giorno trascorrevo ore a parlare con lui di quest’opera. Lui parlava, raccontava, da uomo colto qual era e ricordo che si commuoveva e piangeva. Tanto era l’amore che provava per quel personaggio. Gobbi era un artista sommo. E un grande signore. Non l’ho mai visto rabbuiato, ma sempre sereno>>.
C’è un’opera che hai sempre desiderato interpretare e non hai mai potuto farlo?
<<Ce ne sono diverse. Mi sarebbe piaciuto fare il Boris, ma ora c’è la moda di fare tutto in originale e io non ho voglia di mettermi ad imparare il russo. Anche il Dvozeck mi piacerebbe, ma non conosco il tedesco. In fin dei conti sono contento di quelle che ho fatto. Non ho rimpianti>>.
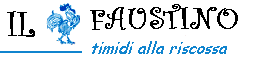 Il Faustino Timidi alla riscossa
Il Faustino Timidi alla riscossa

